Chiara Francini presenta il suo “Le querce non fanno limoni” a Duemilalibri a Gallarate
La rassegna gallaratese ha portato la scrittrice al Museo Maga dove ha presentato il suo ultimo libro

Chiara Francini scrive gli anni di piombo: tra vergogna e coraggio del passato e scelte e critica attuali regalando al pubblico delle letture drammatizzate, Chiara Francini presenta il suo Le querce non fanno limoni nella cornice di Duemilalibri a Gallarate. Gli anni Settanta vivono l’alfabeto della politica. Sono anni più vicini ma più oscuri, cupi. Anni colmi di stragi, che talvolta non trovano compimento. È un periodo che ha sconvolto l’Italia e gli italiani. Che però a scuola non si studia. Di cui non si parla. Che non gode del fascino delle guerre mondiali, della resistenza. Ecco, in questa decade si inserisce lo sguardo acuto di Chiara Francini che tenta con il suo romanzo storico di affrontare quel “buco di storia”.
Studiare la storia, secondo Francini
«Studiare la storia non vuol dire semplicemente guardarsi indietro e vedere cosa si è fatto, ma avere la consapevolezza che il nostro presente è scritto dal nostro passato» insiste la scrittrice, rammentando le parole di Piero Calamandrei pronunciate agli studenti milanesi in occasione delle conferenze universitarie del 1955, e desiderando che vengano imparate a memoria «all’asilo, alle elementari, alle medie…».
Studiare la storia significa per Francini, come per Calamandrei, «studiare come si sta al mondo, e come stare al mondo è il cuore della politica. E se la storia è il nostro passato, la costituzione non è solo un pezzo di carta, ma un pezzo di carta fatto di sangue e di sudore. La consapevolezza è necessaria perché “la libertà è come l’aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”: lo studio e la conoscenza sono l’unica possibilità che abbiamo per essere liberi perché liberati» stocca l’autrice.
La scelta, il senso critico e il coraggio
Il romanzo storico – che seppur storico rimane un romanzo «per la parte che parla alla pancia» – si sviluppa nella toscana degli anni 70. Nella Campi Bisenzio dell’epoca c’è un cantuccio, «un luogo dove la diversità non viene corretta. Una trincea in tempo di pace. La mia esatta idea di famiglia. La Delia è la regina non di questo paradiso, ma di questo inferno bonificato». E “La Delia” è una donna con un passato. E il passato, ovvero la sua storia, determina che La Delia diventi La Delia.
Francini riprende quello che ha scelto come epilogo: «In una vita felice bisogna aver combattuto. Agguantato quello che è giusto per noi. Riconosciuto le proprie forme e i propri colori. C’è la certezza che il tragitto sia fatto di cadute, fallimenti e dolore. Perché come dice la mi mamma “chi è bello sempre, non è bello mai”; anche le donne più felici cadono in un pozzo e cadere serve per avere una prospettiva che mai avremmo potuto avere stando sempre eretti. – aggiunge – Le donne conoscono il dolore da quando vengono al mondo, un dolore che non si vendica, che è fondamentale. Nelle donne è connaturato che il dolore sia parte della vita, forse perché sanguinano una volta al mese» incalza, lasciando un sorriso in bocca al pubblico. «E La Delia ha fatto resistenza col fucile e ha resistito tutta la vita» chiosa.
La Delia è il personaggio delle scelte, dello spirito critico, della necessità di ragionare sulle cose. Su questo punto l’autrice attualizza estrinsecando dal suo scritto: «Il male di questo periodo è la semplificazione autoritaria del pensiero che non lascia spazio per la comprensione. Una semplificazione fatta male genera una fake news».
Prosegue: «La sua scelta, La Delia, l’ha compiuta in tenera età. “Perché i maschi sì e le femmine no?” si chiese quando gli squadristi non toccarono la tata Maria. Si rispose: “se rissa doveva esserci nella rissa ci sarei stata anche io”». Così La Delia diventa anche il personaggio del coraggio, non del furore, piuttosto della consapevolezza, dell’amore per la vita da tenere con cura, rispetto e responsabilità.
Tra storia e invenzione del romanzo storico
Il romanzo è corale e sono plurime le voci che si intersecano, come plurime sono le scelte minuziose di Francini per i personaggi da inserire o cui ispirarsi per le storie da intrecciare. Tra le pagine e dialoghi – talvolta italiani, talvolta toscani – si incontra Bianchi Bandinelli, l’archeologo su cui tutti abbiamo studiato, il ragazzo che fece da guida a Hitler e Mussolini durante la loro visita agli Uffizi del 1938.
Il personaggio del brigatista invece è ispirato all’atteggiamento tenuto dal Riccardo Dura – sebbene successivo al 1973, anno clou nel romanzo. Si tratta di un bambino mandato dalla madre in manicomio, spedito poi sulla nave Garaventa, una nave–riformatorio, dove si politicizzò, entrando dapprima nei movimenti della sinistra extraparlamentare a Genova, per poi approdare alle Brigate Rosse. Francini ammette che nel processo di stesura delle vicende ha dato lettura del saggio Dolore e furore dove sono raccolte le lettere che scriveva alla madre: pagine in cui immaginava che, un giorno, gli sarebbe stato restituito tutto ciò che la vita gli aveva negato. Una scrittura densa, che lascia intravedere un tormento più profondo e più selvaggio di molte altre storie interne alle BR. La sua traiettoria non garantisce che abbia sempre mosso passi giusti nella ricerca, ardente, di una forma di giustizia. E tuttavia, nella sua percezione, quella giustizia l’ha raggiunta – o quanto meno inseguita – fino alle estreme conseguenze. Ci si può qui legittimamente interrogare se leggendo romanzo non ci sia il rischio di romanticizzare questa parte della narrazione, empatizzando e arrivando a comprendere il brigatista e le ragioni che hanno determinato la sua condotta. Francini è chiara «in una logica manzoniana, oggi sono tutti don Abbondio e nessuno è l’innominato, ma quando volevo scrivere dei brigatisti il Che Guevara che cercavo non c’era».
Il primo mantello per del controllo
Francini individua come tema che sottende i precedenti quello che vede il contrapporsi della vergogna e del senso di colpa. «La vergogna è primo mantello che ci mettono addosso per controllarci. È un’arma di controllo istituzionalizzata. A differenza del senso di colpa riguarda ciò che si è e non ciò che si è fatto. Tuttavia, la vergogna non è solo negativa, ma anche strumento per la conoscenza di sé».
Esemplifica servendosi della “villa triste”, così erano chiamati i luoghi di tortura per dissidenti: «Quando si chiedeva a chi avesse avuto la sfortuna di frequentarli cosa fossero, la risposta standard era “non te lo posso dire perché non trovo parole nemmeno in dialetto”. Le partigiane venivano abusate. Non denunciarono mai. Mancava l’alfabeto, c’era un vuoto semantico, ma il senso di colpa – nelle vittime anziché nei carnefici – era totalizzante». L’appello allo studio della scrittrice si fa più morale e civico: «studiare per restituire dignità a queste donne».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Entrano in vigore le nuove tariffe "metropolitane", Saronnese e Busto più vicine a Milano
Felice su Fucile d'assalto e mitragliette nella casa dell'ex ispettore di Malpensa
lenny54 su In vendita casa Bossi, villa simbolo della "Lega di una volta"
lauralaura su Ospedali troppo caldi: la Regione comprerà i condizionatori
gcbiakmw su Lo spinello fa male
Rita Campiotti su Torna IceOut, qual è la vostra gelateria preferita?



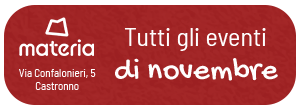









Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.